Lucky Red, distributore italiano del film, ha deciso di riportarlo in sala in occasione della Festa della Liberazione.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a febbraio in redazione.

Trad. di Amaranta Sbardella
Non abbiamo mai avuto grande passione, in Italia, per la letteratura della penisola iberica. Poche eccezioni: Javier Marías, grandi scrittori e grandi scrittrici però di genere, pochi altri nomi altisonanti che sembrano però cattedrali circondate dal deserto. Nel dicembre 2024 ho letto con un entusiasmo diffuso, almeno tra le lettrici e i lettori forti in Italia, Tagliare il nervo della catalana Anna Pazos. Forse qualcosa sta succedendo, perché già a gennaio 2025 Mondadori lanciava nelle librerie Il tempo delle ciliegie, il più importante romanzo della catalana Montserrat Roig, vincitore del Premi Sant Jordi. Roig non è una scrittrice contemporanea, cioè vivente: è morta nel 1991 (era nata nel 1946), ma forse c’entra anche la politica di questi mesi in questa riscoperta, nello specifico il fatto che la Spagna, ancora una volta nel giro di due decenni (ci ricordiamo il mito di Zapatero?) sia una lucina di speranza socialista in un’Europa sempre più nera. E poi perché quello che racconta Roig è un grande romanzo familiare e borghese in un Paese immerso in un fascismo peculiare come fu quello franchista, anticipo di quella che oggi chiamiamo “democratura” e che in Europa vediamo in Ungheria, in Turchia, e chissà in quali altri Paesi nei prossimi anni. Ma al netto della politica, Il tempo delle ciliegie è un libro con un grande valore letterario: è un grande quadro pieno di dettagli quello della famiglia Miralpeix, che lentamente decade con il tempo, come le sue case sempre più trascurate, come le tende di velluto fuori moda che si riempiono di buchi. Colpa degli anni, dell’impoverimento, delle sfortune, della modernità che si mangia il blasone. E poi la storia di Natália, che è tornata a Barcellona dopo 12 anni all’estero, è il 1974, qualcosa è cambiato ma non troppo, la violenza ha vinto, ma manca soltanto un anno alla morte di Franco. C’è da fare i conti con la famiglia e come è cambiata, con il Paese che freme, con il cugino che è diventato un adolescente, con il passato e i motivi per cui se ne era andata. Il tutto è narrato con una voce elegante, piena di atmosfere e attenta ai dettagli. (Davide Coppo)

Riccardo Meozzi, Addio, bella crudeltà (Edizioni E/O)
Leggendo questo romanzo ho ripensato allo stupendo Sylvia di Leonard Michaels: ci ho ritrovato il senso di claustrofobia e angoscia che soltanto una relazione tossica raccontata bene riesce a trasmettere. Se la storia raccontata in Sylvia, però, è una storia di amore e malattia mentale, quella raccontata dall’esordiente Riccardo Meozzi è una storia d’amore che si mescola con una malattia, se possibile, ancora più complessa, perché tocca sia la mente che il corpo. Qui il malato della coppia non è la donna, ma l’uomo, Giovanni, che all’inizio ci viene presentato, attraverso gli occhi adoranti della protagonista femminile, Lidia, come quello che una Gen Z definirebbe “malessere”: un bellissimo ragazzo (alto, riccioli neri) che soffre di misteriose emicranie e ha una preoccupante tendenza all’aggressività fisica e verbale, uno stronzo dal quale Lidia non riesce a staccarsi, nonostante le “red flag” siano, fin da subito, abnormi. L’intesa sessuale tra i due è così intensa, e Lidia è così innamorata, o meglio, così psicologicamente e fisicamente dipendente da lui, che nonostante la giovane età (intorno ai vent’anni) decidono di sposarsi. Dopo il matrimonio, però, a Giovanni succede una cosa tragica, e il loro rapporto si trasforma, le dinamiche di potere cambiano. È come se attraverso la malattia lo scrittore volesse evidenziare ulteriormente le dinamiche della relazione tossica, mostrando come anche di fronte a una situazione così estrema, così apparentemente “ribaltata” (lui impotente, lei dominante) la violenza di Giovanni e la forza passiva di Lidia continuino a scontrarsi e a provocare dolore. L’ambientazione scelta da Meozzi rende questa storia ancora più bella e disperata: gli anni Novanta, i campi, i casolari e le discoteche della provincia italiana. E per chi, come me, ha vissuto l’esperienza di amare dei malesseri, segnalo un pensiero da sottolineare e in cui ritrovarsi: «Lei sapeva che non avrebbe dovuto esserci spazio per lui perché non poteva fare a meno di bere, perché scompariva, perché aveva carezzato i capelli di una ragazza mentre la baciava e aveva invece tirato i suoi, perché la seguiva nel buio e una notte l’aveva terrorizzata. Però il dolore di Giovanni le era più comprensibile del proprio, e questo era tutto e lo sarebbe stato per sempre». (Clara Mazzoleni)
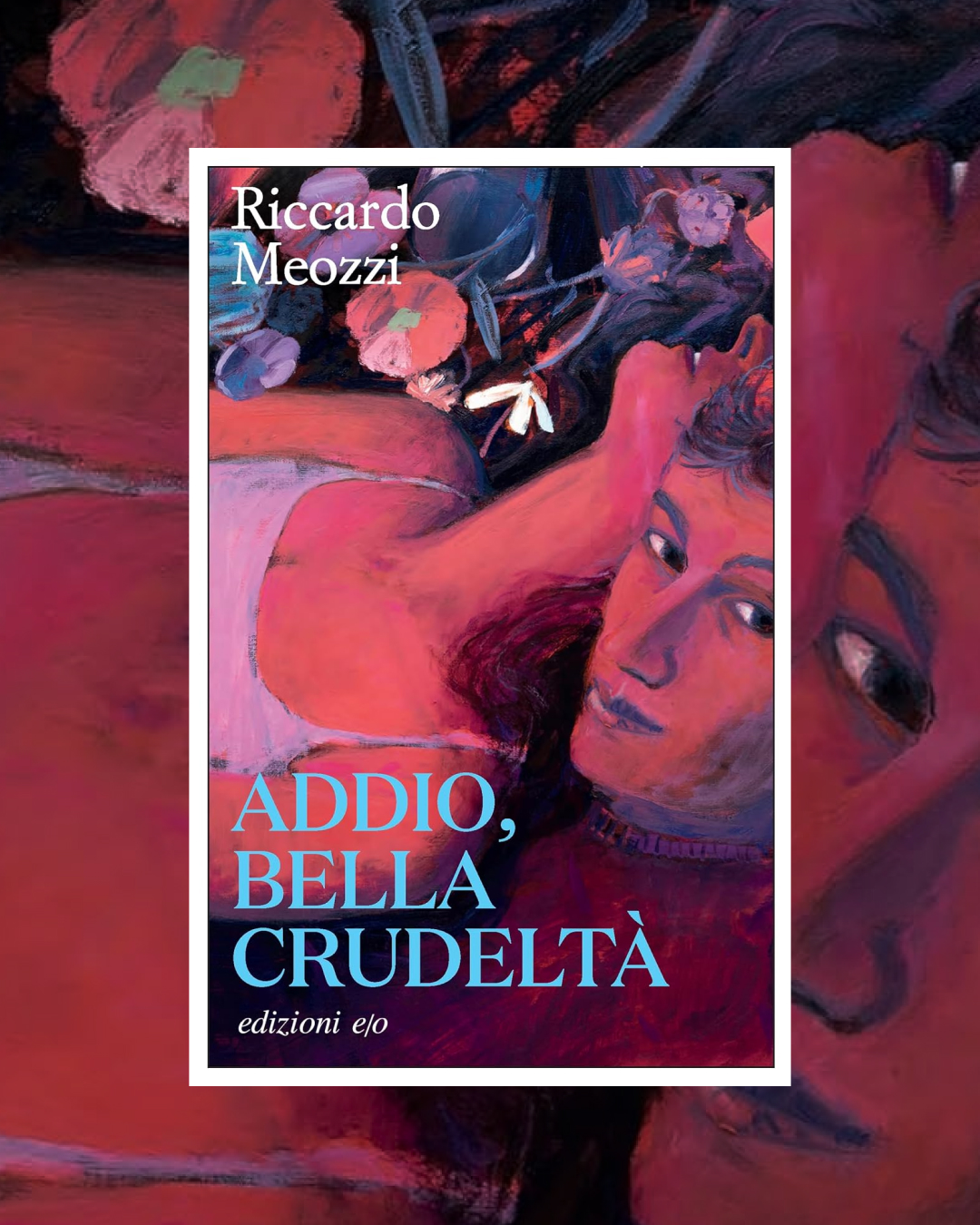
C.F. Ramuz, Presenza della morte, Feltrinelli
Trad. di Maria Nadotti
È possibile che il primo essere umano a intuire la brutta fine dell’umanità sia stato uno svizzero francofono la cui unica passione erano i paesaggi e la natura del Canton Vaud? La risposta è sì: Charles-Ferdinand Ramuz l’apocalisse l’ha vista arrivare e pure da lontano. Presenza della morte è del 1922, periodo in cui sarebbe stato facile dire che l’umanità si sarebbe estinta a furia di guerre (non che questa previsione fosse sbagliata, abbiamo solo trovato modi più veloci e letali di farci fuori a vicenda, la guerra la pratichiamo ancora ma perché ci piace, non perché ci serve). Le guerre però sono cose del mondo e a Ramuz il mondo interessava assai relativamente: gli piaceva il suo cantone ed è lì che ha notato i segni di quel che sarebbe successo. Nell’estate del 1922 si registrarono temperature assurdamente alte a Ginevra, anomalia che tutti presero con buonumore: gite al lago anticipate, donne in abiti leggeri, che si può chiedere di più. Ma Ramuz, attento com’era agli equilibri delle cose, passò quell’estate a rimuginare, facendosi la domanda che a nessuno interessava porre: ma perché fa così caldo? L’immaginazione (in realtà era ecoansia, in anticipo di cento anni) lo portò fino alle estreme conseguenze di quella banalissima anomalia nei corsi e ricorsi climatici: prima o poi, è scritto nelle leggi dell’universo, il sole inghiottirà la Terra e forse questo è il momento in cui la stella inizia a spalancare le sue fauci infuocate, pensava, mentre tutti se ne andavano a fare il bagno al lago. Presenza della morte sarebbe bello poterlo definire una distopia, una versione alternativa e disperata di una storia che nella realtà non si è manifestata così gravemente. Purtroppo non è andata così, frase che ci si ritrova a ripetere sempre più spesso a leggere questi libri: nella realtà ci è andata peggio delle peggiori aspettative. E quelle di Ramuz erano parecchio fosche: quando gli esseri umani capiscono che la campana sta suonando per loro, si abbandonano a eccessi di violenza tribale e insensata, descritti in pagine incredibilmente esplicite. Il fatto che questa sia finzione, però, si capisce dalla redenzione finale: nei loro ultimi istanti, gli esseri umani vivono un’epifania che li salva («ho amato solo l’esistenza», si legge in uno dei passi più struggenti del libro), almeno agli occhi dell’universo di cui hanno fatto miseramente parte. Nella realtà, lo sappiamo, lo stiamo capendo, non andrà così: l’umanità finirà continuando a fare il bagno al lago mentre il fuoco delle stelle brucia il mondo intero. (Francesco Gerardi)

Annalisa Ambrosio, L’amore è cambiato (Vele Einaudi)
Ci sono degli argomenti che, nonostante il ridisegno quasi completo di ciò che ci circonda negli ultimi decenni, continuano a mantenere degli elementi piuttosto saldi al modo in cui li abbiamo sempre conosciuti. In realtà il tentativo di approfondirli e spiegarli è incessante. L’amore è uno di questi, ed è forse quello che viene tirato più spesso per la giacca nel tentativo di comprenderlo, decifrarlo, adattarlo al contemporaneo, un po’ come abbiamo provato a fare con tutto in questi anni velocissimi. Quello con cui abbiamo avuto forse i risultati più scarsi. Certo, anche l’amore ovviamente è cambiato, ed è proprio questo il titolo del breve saggio di Annalisa Ambrosio. L’amore è cambiato parte da un’intervista a Michela Murgia dove provava a definire cos’era per lei amare, che non era «un sentire, ma un fare» e proprio da questo sentire, molto tipico della fase iniziale, dell’innamoramento, che voleva allontanarsi, proprio come da una malattia. In queste poco più di cento pagine, Ambrosio prova a rispondere alla domanda se è possibile superare il mito tradizionale dell’amore romantico, quello che passa dall’innamoramento al vissero tutti felici e contenti e che tanti danni sembra avere fatto. Nella difficoltà del parlare d’amore – o nella paura di farlo, come sosteneva bell hooks – questo saggio apre alle varie possibilità contemporanee e future dell’amore, che assomiglia e assomiglierà forse più a un patto, a un poliamore, a un qualcosa che sa già che non sarà per sempre, provando però a non buttare via tutto quello che c’era prima. Quel sentire, da cui si vuole allontanare come da una malattia debilitante Murgia, per Ambrosio è invece energia e bellezza che può essere convogliata perché quasi sovrannaturale ed estrema esemplificazione di ciò che ci rende vivi. Quell’energia è l’innamoramento, fonte di struggimenti e di aspettative che secondo l’autrice possono essere vissute lo stesso se si colgono gli aspetti positivi, in un certo senso guidandole, ripulendole, in modo da essere adatte anche per il mondo e l’amore che verrà. È vero, parlare d’amore è difficile, come con le cose che sfuggono di mano e dai codici, e proprio per questo se da un certo punto di vista farlo tentando di mettere freni e confini può risultare inutile e fastidioso, è pur sempre un modo per metterlo sul tavolo, discuterne magari animatamente provando a scoprire un’altra faccia ancora sconosciuta delle sue ragioni. Un’altra mutazione di questo virus, nonostante non ci sia ancora alcun vaccino. Per fortuna. (Teresa Bellemo)
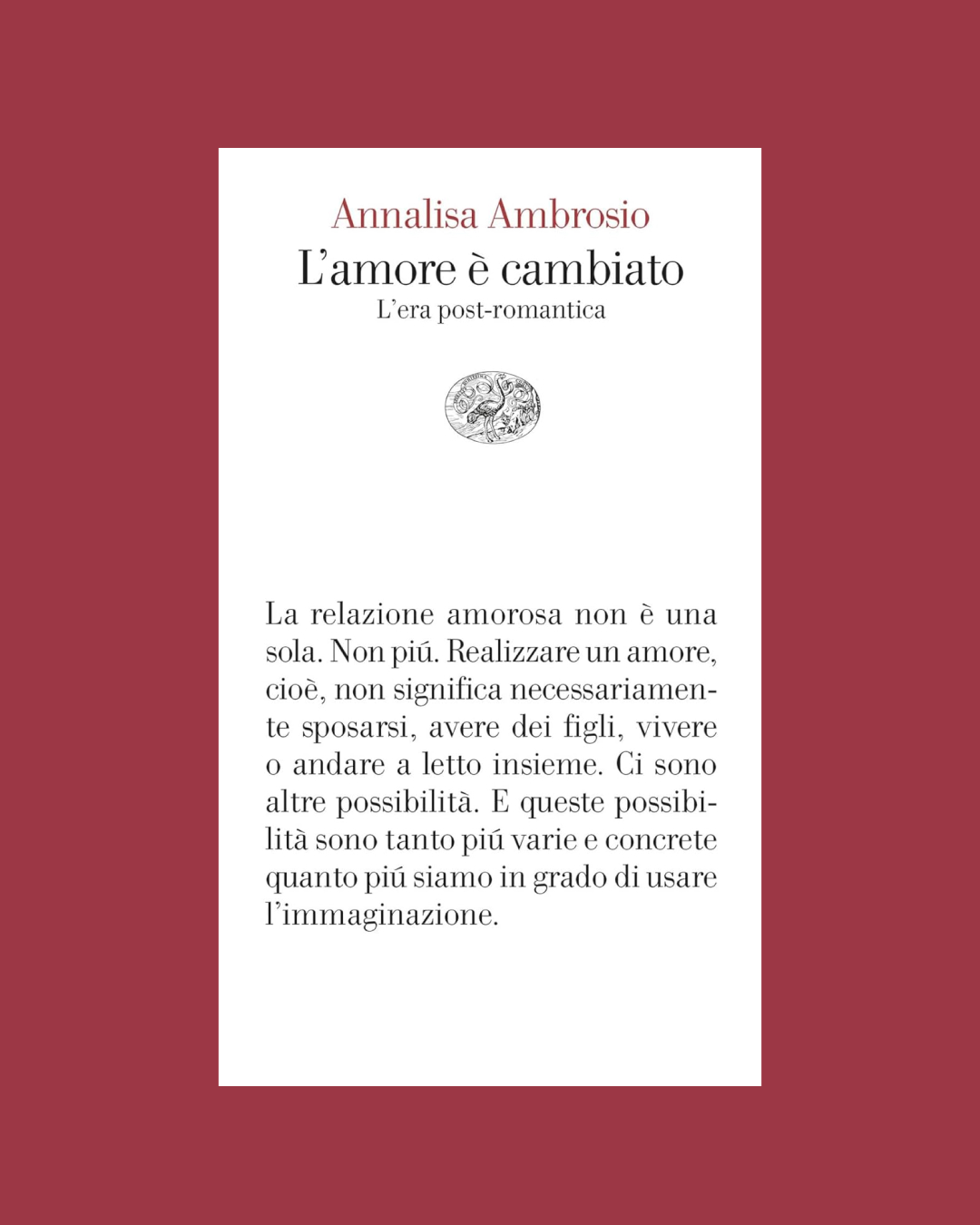
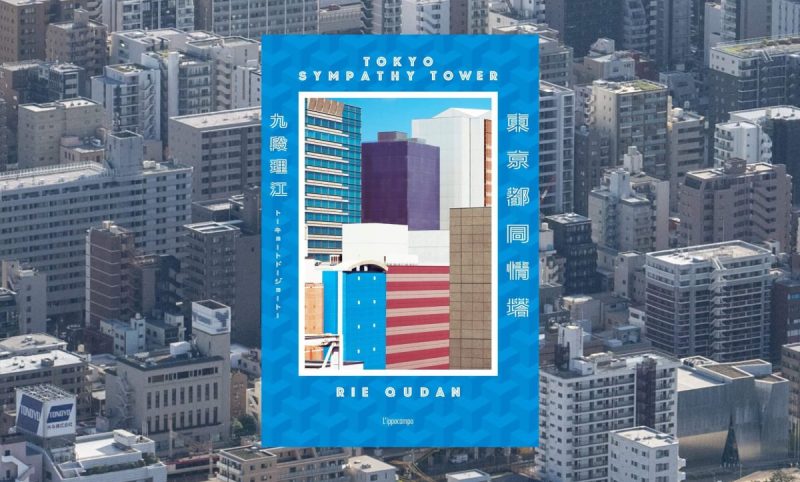
Subito dopo la vittoria dell'Akatugawa Prize, il Premio Strega giapponese, la giovane autrice Rie Qudan ha detto di essersi fatta aiutare dall'AI per scrivere il romanzo. E di essersi trovata benissimo.





