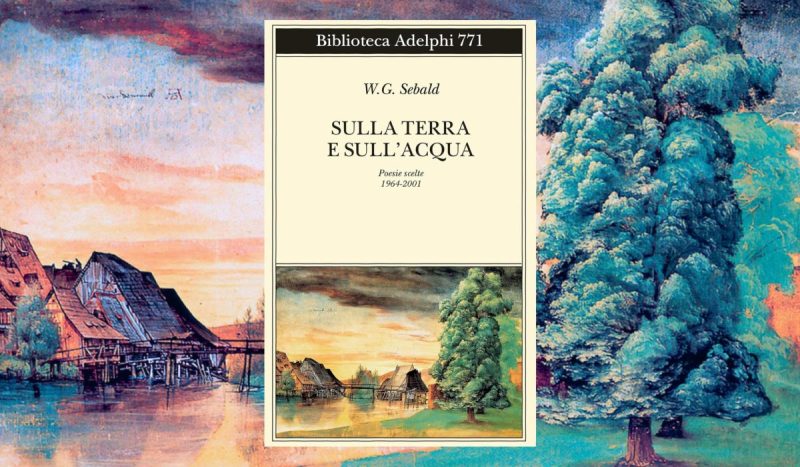Negli ultimi anni diversi autori e autrici hanno ambientato i loro libri in giro per l’Europa. Anche le loro vite lo sono. Hanno dei tratti in comune? E come si rapportano con la crisi dell’Europa di oggi? Una conversazione a più voci.
Alberto Méndez, I girasoli ciechi (Sellerio)
Traduzione di Bruno Arpaia
Visti i tempi, è inevitabile cercare nella letteratura (nelle arti, tutte) la risposta alla domanda: ma com’è che il fascismo esce dalla porta e rientra dalla finestra? La migliore letteratura di resistenza – lo ammetto, una definizione lasca ma comprensibile e affascinante – a questa domanda dà sempre la stessa risposta: vallo a sapere, com’è che succede. Lo sapessimo, le persone non sarebbero morte per combatterlo né sopravvissute per raccontarlo, il fascismo. Alberto Méndez ha cercato una risposta a questa domanda per tutta la vita: il risultato è I girasoli ciechi, un romanzo pubblicato quando aveva 63 anni, che è riuscito a far pubblicare con le ultime forze che il cancro gli aveva lasciato (è morto nel 2004, Méndez, poco dopo la pubblicazione del libro). Ovviamente, in tutto il libro non c’è una risposta che sia una: perché la dittatura franchista è successa, perché è durata, perché ha vinto, Méndez non lo sa. E, si può supporre, nemmeno gli interessava. È un libro sul come, I girasoli ciechi: come esistono gli esseri umani sotto un tiranno? Come muore un ribelle e come vive un fascista? Come si fa a capire la differenza tra un povero disgraziato che ha combattuto Franco e un povero disgraziato che ha combattuto per Franco? Nella miseria, come proteggiamo le nostre fedeltà? I girasoli ciechi racconta quattro storie e per quattro volte non trova la risposta a nessuna domanda. Racconta di un capitano franchista che diserta e si consegna ai repubblicani quando capisce che i suoi non vogliono vincere ma ammazzare. Racconta di un uomo in prigione che si inventa storie sul figlio del suo carceriere, per convincere quest’ultimo a portargli un altro pasto, farlo vivere un altro giorno, ascoltare un’altra storia. Racconta di un prete innamorato di una donna che nasconde il marito ribelle in un armadio, due peccati per due disperati. Racconta, infine, di un poeta comunista che scappa insieme alla fidanzata incinta. Provano ad andare in Francia, ma lei muore durante il parto e a lui resta, probabilmente, la risposta che Méndez aveva trovato a quelle domande. Al poeta, alla fine, restano una figlia, qualche foglio di carta e una penna. Che, in fondo, è quel che resta a tutti quelli che sopravvivono al fascismo: la vita e la memoria. (Francesco Gerardi)
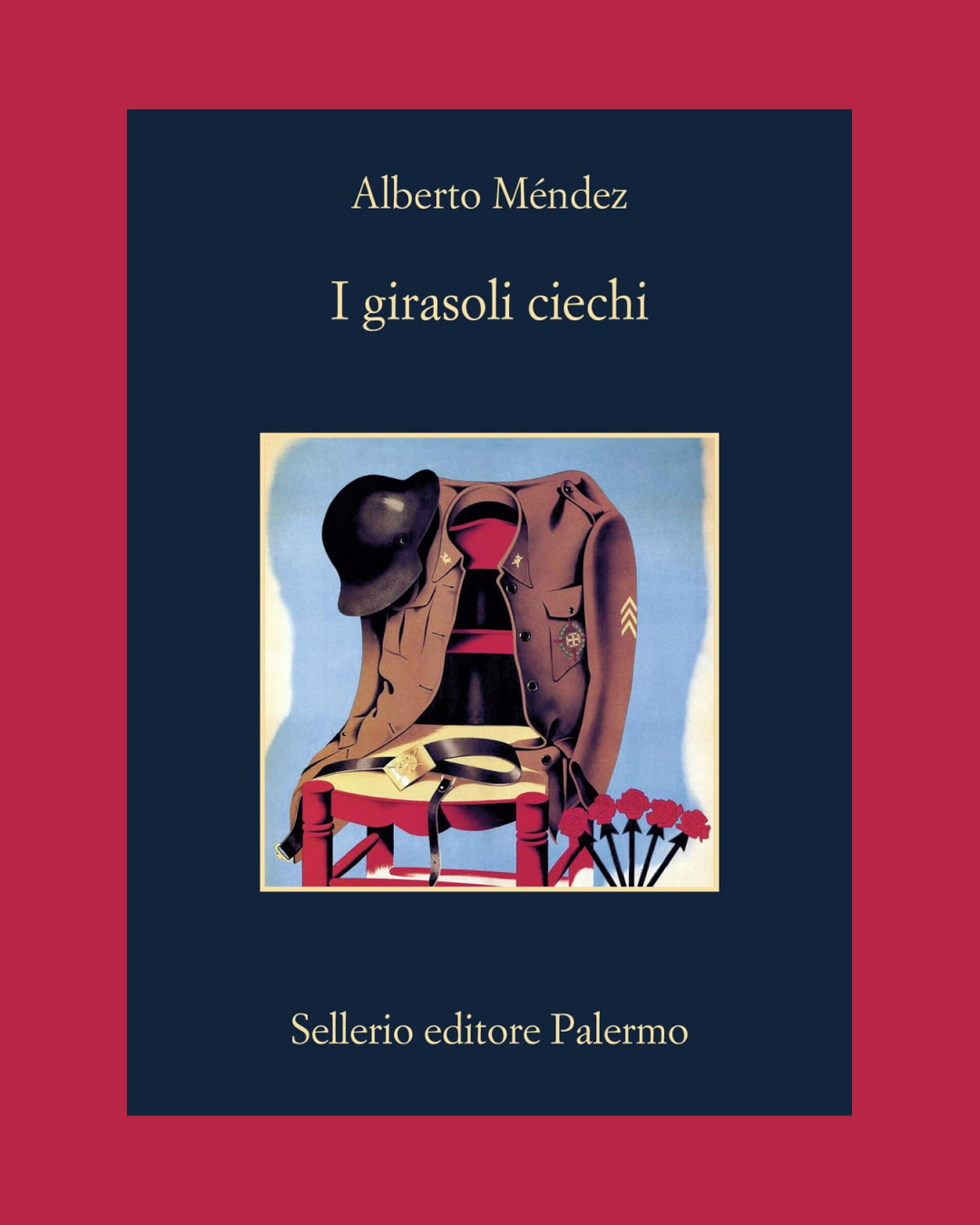
Boris Akunin – L’avvocato del diavolo (Mondadori)
Traduzione di Erin Beretta, Francesco De Nigris, Mariangela Ferosi, introduzione di Paolo Nori
Che nostalgia il romanzo russo, quello su cui tanti di noi hanno costruito la propria autoformazione letteraria. Perché se ci si voleva formare su classici che non fossero esattamente quelli che si studiavano a scuola, ma qualcosa di leggermente più vicino alla sensibilità di lettori del Ventesimo secolo, bisognava prendere i francesi e, appunto, i russi. I nomi li sappiamo, inutile farli. Più che altro è incredibile pensare quanto la letteratura russa, coi suoi caposaldi, abbia fatto parte di noi e quanto, invece, più avanti negli anni, sia stata obliterata. Non necessariamente per colpa nostra, questo va detto, perché a parte pochi nomi, la letteratura russa contemporanea non solo non è stata più tradotta, ma forse non è mai neanche stata scritta (per ragioni storiche non impossibili da ipotizzare). Nell’introduzione di questo libro, Paolo Nori racconta attraverso un aneddoto uno dei segni di questa decadenza. Ed è la sua ambivalenza rispetto al trovare e poi non trovare più in Russia (a partire dal luglio del 2022) libri di Sorokin e Akunin, i due maggiori scrittori russi contemporanei (se si trovano vuol dire che non sono poi pericolosi, ragiona Nori, ma se poi non si trovano più?). Di sicuro sarà difficile trovarci L’avvocato del diavolo, novella scritta propria da Akunin, ambientata in un futuro molto vicino e che innanzitutto ci riconcilia con la possibilità di una letteratura russa, oltre che con la sua nostalgia. L’altro motivo di interesse per questo breve libro gogoliano, che immagina un ennesimo ciclo di morte e rinascita per l’autocrazia russa, ambientato in una serie di scene televisive, carcerarie e processuali, è il rinnovato contatto con quell’intelligenza amara, con quella saggezza cinica. Se avete voglia di ricordare che “i russi” sono un groviglio complesso e affascinante e non soltanto un lato dell’Europa così oscuro da essere monocromatico, questo libro potrebbe fare al caso vostro. (Cristiano de Majo)
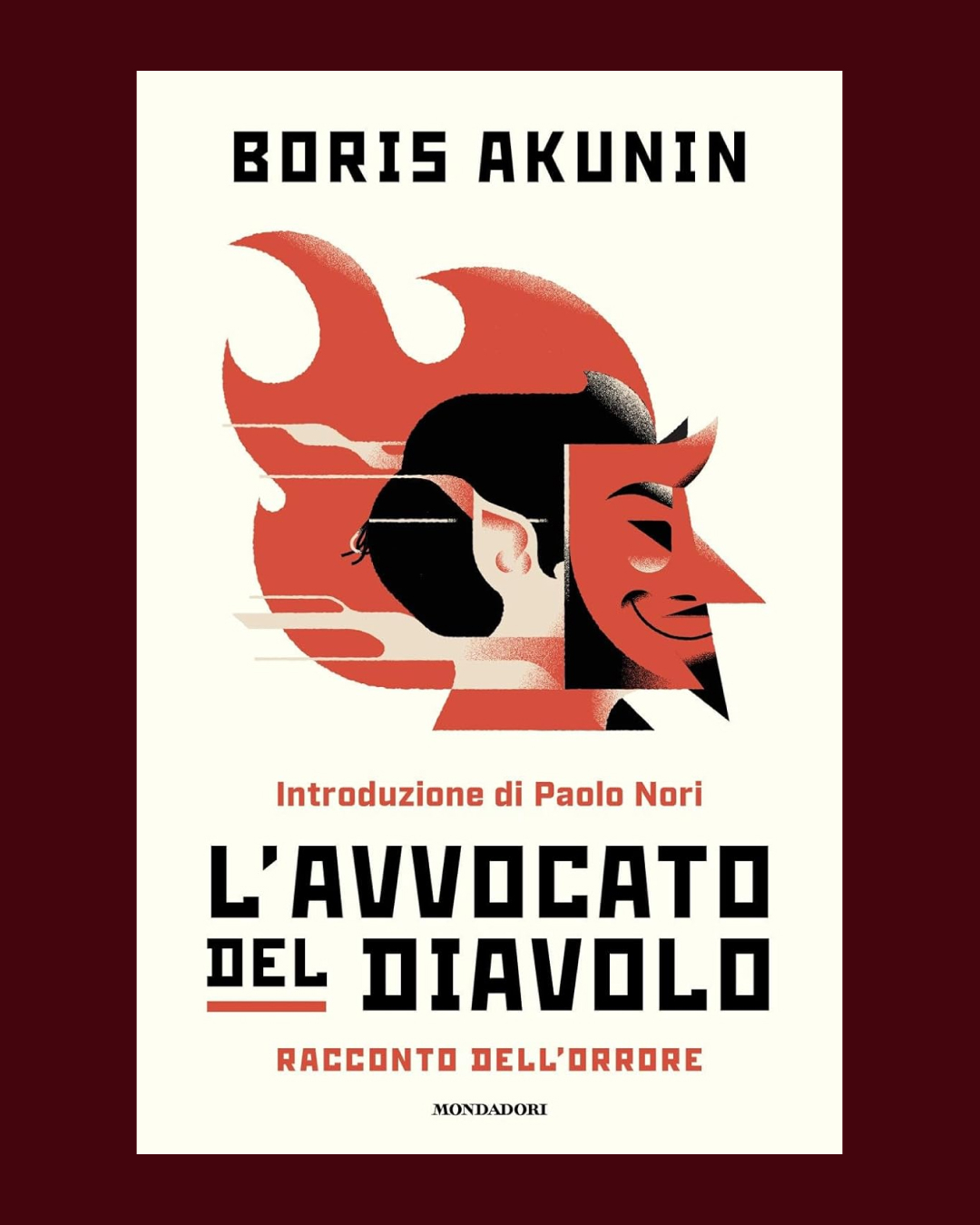
Deborah Davis, Andy Warhol 1963, destinazione Los Angeles (Accento)
Traduzione di Sara Reggiani
Come tutti ho studiato Andy Warhol al liceo, ma ho iniziato ad amarlo davvero grazie a una delle migliori mostre a lui mai dedicate, quella del 2005 alla Triennale di Milano, The Andy Warhol Show, che lo presentava non solo come un artista, ma anche come uno scrittore-filosofo. L’ho poi ritrovato all’università, studiando prima pittura e poi critica d’arte, e nei libri che ho letto negli anni successivi (le più belle pagine su di lui sono forse quelle di Olivia Laing in Città sola, 2016, in realtà dedicate alla donna che cercò di ucciderlo, Valerie Solanas). La serie Netflix del 2022, prodotta da Ryan Murphy e con la voce di Warhol che legge frammenti dai suoi diari ricreata con l’AI, mi aveva convinto a comprare The Andy Warhol Diaries, dei diari così belli da meritare il posto d’onore accanto ai diari di Patricia Highsmith, di Virginia Woolf e di Sylvia Plath. Tutto questo per dire che ormai, ogni volta che mi imbatto in un nuovo libro, mostra, articolo o documentario su Andy Warhol penso: madonna che palle, basta. È la stessa reazione che ho avuto di fronte al libro di Deborah Davis. Ho iniziato a leggerlo solo perché mi ricordavo che Davis è una che sa tenerti attaccato alla pagina anche quando parla di personaggi ultra mitizzati di cui sembra davvero difficile conoscere qualcosa di nuovo, come fa nel bellissimo Truman Capote e il party del secolo. Questa volta la scrittrice si concentra su un viaggio, un americanissimo road trip ma anche una sorta di pellegrinaggio, intrapreso da Warhol all’inizio degli anni Sessanta, quando è già un illustratore affermato ma non ancora un vero e proprio artista, alla scoperta, per la prima volta, della tanto sognata e immaginata Hollywood. Davis non si limita a raccontarlo: ha ripercorso lei stessa, guidando, ogni tappa del viaggio dell’artista, ricostruendolo grazie agli scontrini, alle ricevute e ai vari oggettini contenuti nelle sue famose “capsule del tempo” (le scatole che riempiva con le cianfrusaglie che raccoglieva ogni giorno). Incredibilmente, Davis riesce a raccontare qualcosa di nuovo sulla vita e sull’arte di Andy Warhol, facendo ri-innamorare di questo artista così fragile e così potente perfino i suoi fan più nerd ed esperti. (Clara Mazzoleni)
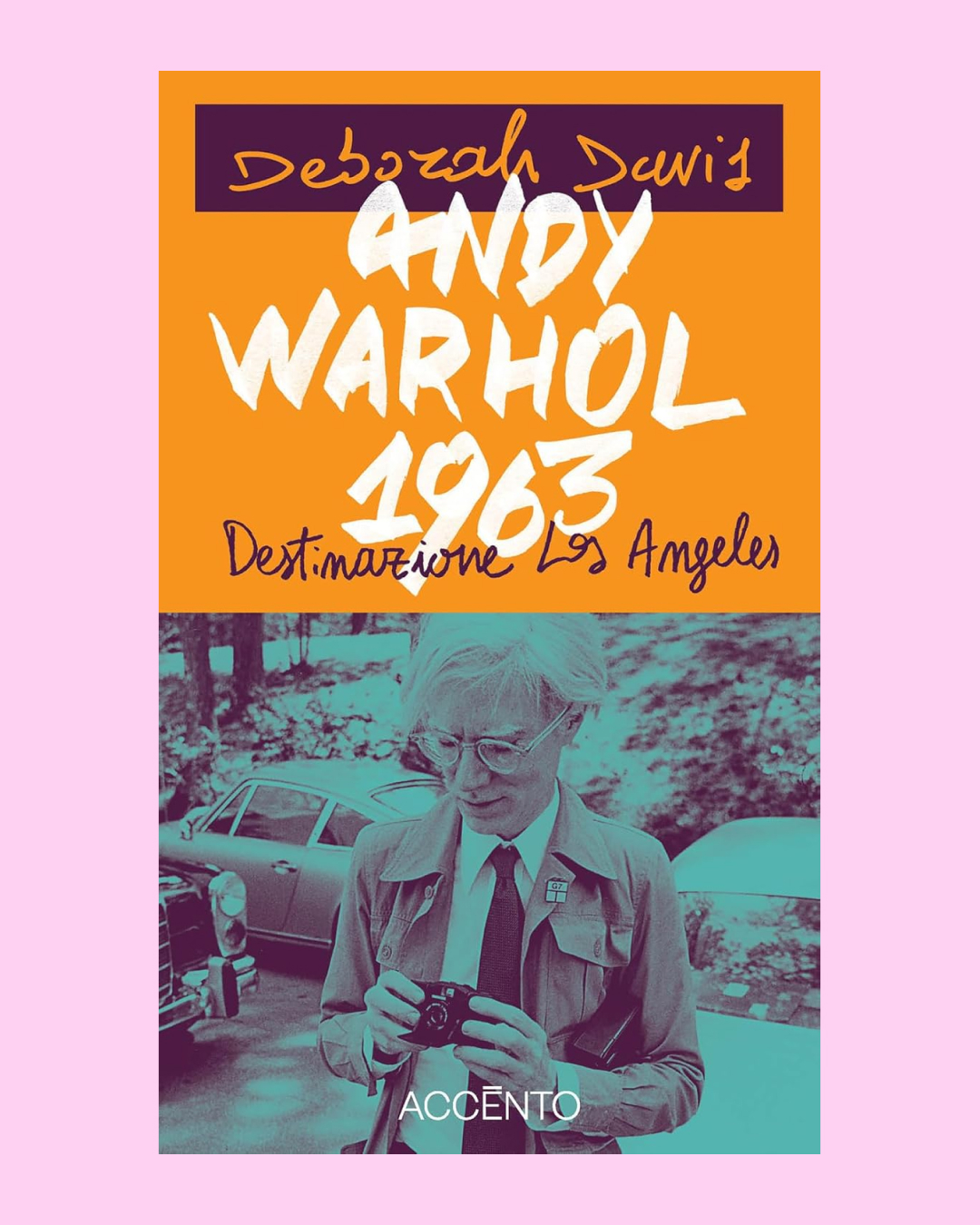
Leonardo San Pietro, Festa con casuario (Sellerio)
Quando me l’hanno raccontata, alcuni mesi prima dell’uscita, mi è sembrata una trama incosciente e selvaggia, e mi piaceva: una festa di ventenni in una villa di una giovane ricca torinese, e una sfida assurda nata da un mistero: bisogna toccare il casuario della vicina di villa, o un loro amico morirà. Il casuario è un animale divino e pericolosissimo. Coraggioso e spregiudicato questo inserirlo in un contesto altoborghese sulle colline che guardano il Po. Scorre veloce questo romanzo d’esordio, alternando i capitoli tra i protagonisti, tutti equivalenti, che si drogano e ballano e poi si angosciano alla scoperta del bigliettino che dice: qualcuno deve toccare il casuario o Ezio morirà. Anche la lingua è selvaggia, fuori da tutte le lingue che mi sembra di leggere ultimamente, ben curate e ben studiate, o barocche e piene di orpelli, o americane o sudamericane. Mi sono chiesto se fossi invecchiato improvvisamente perché, dalla collina dei miei quasi 40 anni, leggo questi ragazzi che parlano così e penso: finalmente un romanzo di ventenni come si deve, e cioè pieno di ritmo e anche si ingenuità, di coraggio e divertimento, esattamente il romanzo d’esordio di uno scrittore di venti e qualcosa anni che non cerca di imitare Carrère, o Bolaño, o non so quale altro maestro, ma scrive una storia di energia pura, che piuttosto ricorda un Santa Maradona per i nati nel 2000, o i ragazzi terribili di Solo vera è l’estate di Pecoraro (per me, uno dei migliori romanzi italiani dell’ultimo decennio). Con i suoi difetti: certe parti introspettive scontano una poetica universale giovanile un poco banale, anche se sentita. Ma evviva questa spregiudicatezza, questa lingua, questa invenzione. Farmi sentire una scossa di ubriachezza anziché una carezza di saggezza: un risultato che non ricevevo da molto, da un libro. (Davide Coppo)
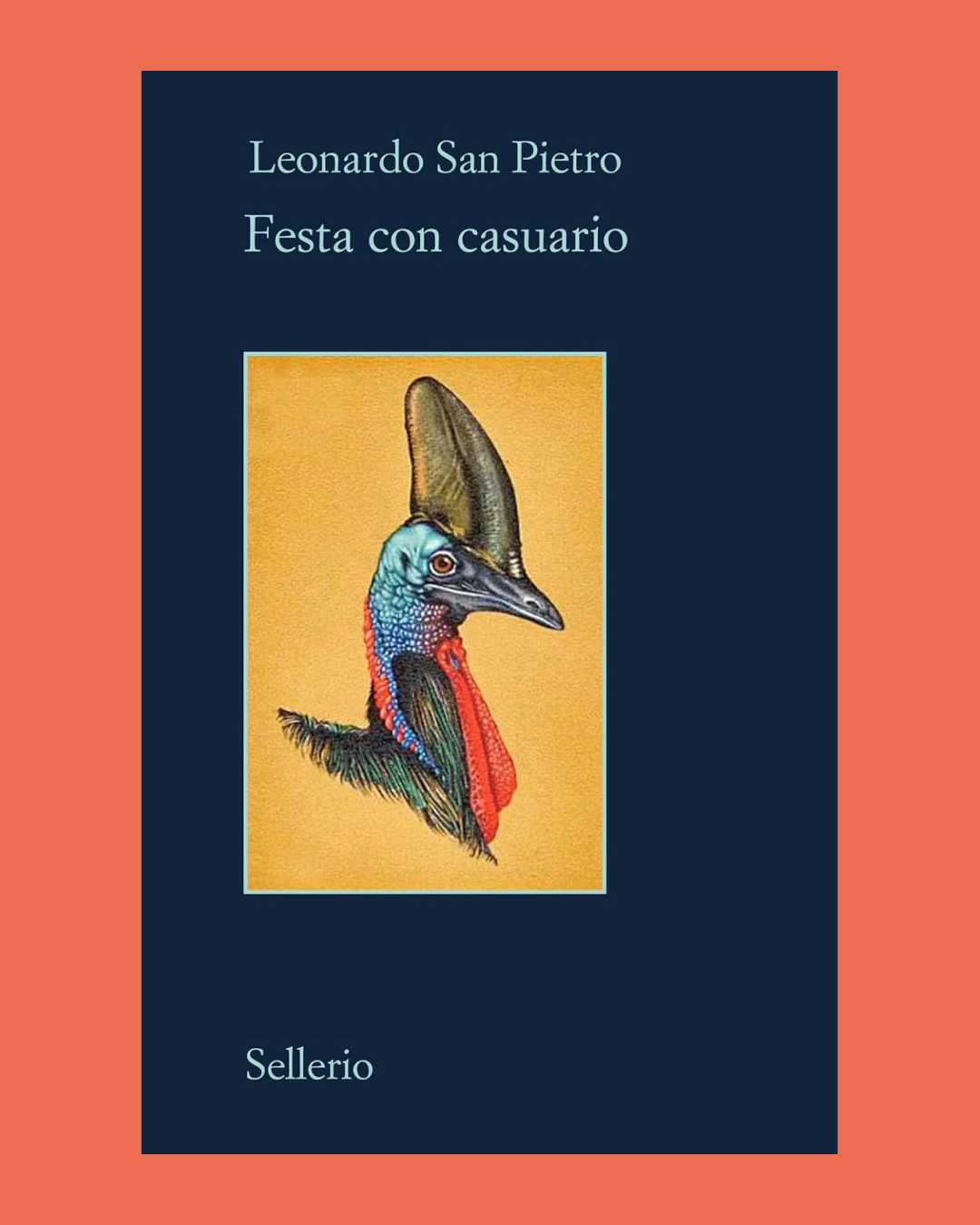
Marina Pierri, Gotico salentino (Einaudi)
Una giornalista quarantenne, che la sua carriera l’ha fatta a Milano, alla morte del padre si ritrova con un’eredità che avrebbe volentieri lasciato da parte per ancora molto tempo. Per la protagonista di Gotico salentino (Einaudi), il romanzo d’esordio di Marina Pierri, quel lutto diventa infatti una sorta di spartiacque, un reset come lo sono i quarant’anni, che si concretizza nel ritorno forzato alla terra natia e, nello specifico, alla casa dove ha trascorso l’infanzia. Una casa padronale nel cuore dell’entroterra salentino, lo stesso che negli ultimi vent’anni, al passo con la turistificazione delle coste pugliesi, è diventato la cartolina di sé stesso, ricoperto di un’autenticità mercificata in masserie ristrutturate cinque stelle lusso, corsi di orecchiette per anglofoni, campagne per salvare gli ulivi dalla Xylella. Il Salento, come le città d’arte e la Sicilia, è uno di quei luoghi in Italia in cui abbiamo visto gli effetti drammatici del turismo di massa, e quello in cui forse, più che altrove, le promesse di una rinascita economica sostenibile si sono infrante. Pierri racconta una storia di emigrazione di ritorno, una storia italiana che però ha i contorni di un romanzo gotico, ispirata al lavoro di autrici come Mary Shelley e Shirley Jackson. La casa al centro della storia è ovviamente infestata e Filomena Quarta, che da bambina vedeva i morti come Mischa Barton ne Il sesto senso, deve affrontare questa malombra, come la chiamano i suoi compaesani, per liberarsene una volta per tutte e far luce sulla sua storia famigliare (il suo è un cognome importante, di costruttori arricchiti, a me ha fatto pensare al caffè che tutti da Lecce in giù ci portiamo a Milano). La malombra ha un nome, un cognome e anche una sorta di curriculum: è Orlando Trispét, una suora che veste di bianco, chissà da dove viene, sicuro è arrabbiata perché, ho pensato leggendo, le anime devono uscire dalle finestre quando muoiono, mi avevano detto da bambina alla prima veglia a cui ho partecipato, e lei evidentemente non è uscita perché nessuno le ha aperto. Pierri utilizza la formula del gotico per raccontare tante storie diverse: una generazione di migranti interni, dal Sud al Nord e poi di nuovo al Sud, la perdita di un genitore, i legami di sangue, quelli con la terra d’origine, il rapporto con i simboli. In una qualche forma, Dimora Quarta è esistita, ha raccontato Pierri a Vanity Fair, ed è lei la vera protagonista della storia, come in una serie di Mike Flanagan: se c’è un posto dove i muri parlano, o «sono di carne», sono abbastanza sicura sia quel lembo di terra. (Silvia Schirinzi)