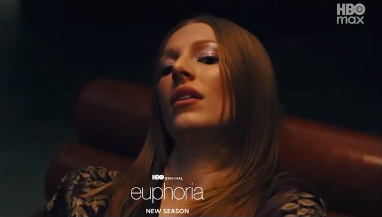Il libro, uscito 20 anni fa in Francia ma solo adesso in Italia, è il racconto in immagini e parole della breve storia d'amore con il fotografo Marc Marie, attraverso il quale Ernaux tocca tutti i temi che caratterizzano la sua letteratura.
Gene Hackman è stato tutto tranne che un uomo qualunque
A 95 anni è morta una leggenda del cinema americano, tutto il contrario dell'everyday man che spesso ha interpretato: Hackman era un uomo spericolato e contraddittorio, che amava fare film e detestava essere famoso.

Il suo primo premio Gene Hackman lo ha vinto quando aveva 27 anni e andava ancora alla Pasadena Playhouse, prestigiosa istituzione di arte e spettacolo della California, presso la quale Hackman frequentava un corso per più o meno giovani che volevano imparare a recitare. Il premio era quello alla “Persona con le minori probabilità di avere successo” e glielo assegnarono i suoi compagni di corso, convinti che quel ragazzone che aveva passato più di metà della sua adolescenza come radio operatore dei Marines fosse troppo strano per fare l’attore: aveva le orecchie a sventola, la mascella prominente, un orrendo taglio di capelli, si vestiva come uno che non si pone il problema di come vestirsi, il suo corpo aveva proporzioni tali che la goffaggine nei movimenti era una condanna. «Io sembravo un minatore, loro dei surfisti», diceva Hackman di sé e dei suoi colleghi.
Sono tante le storie di successo che iniziano con un’umiliazione così, negli Stati Uniti i trionfi degli scartati si vendono a mazzi. Ma ad Hackman non fu lasciata nemmeno la consolazione di sentirsi speciale, anche se speciale per il motivo sbagliato. Quel premio i suoi colleghi non lo assegnarono solo a lui, infatti. Fu una vittoria ex aequo con un altro compagno, un beatnik 19enne che tutti in quella classe detestavano: Dustin Hoffman. Hackman e Hoffman divennero amici in quel periodo e rimasero tali per la vita (il duo poi divenne un trio quando si aggiunse Robert Duvall, tutti e tre furono protagonisti di un favoloso ritratto di gruppo scritto da Richard Meryman su Vanity Fair).
Hoffman ha raccontato che i momenti più surreali della sua esistenza hanno tutti per protagonista Hackman. La sera uscivano spesso assieme e altrettanto spesso capitava che Hackman lo mollasse lì, da solo, all’improvviso, perché decideva che era arrivato il momento di «trovare qualcuno con cui menarsi. Se ne andava per cercare il bar giusto». I bollenti spiriti, il giovane arrabbiato, si potrebbe dire. È vero, ma Hackman arrabbiato ci è rimasto fino alla terza età: l’ultima volta che ha fatto a botte aveva 72 anni, litigò con due tizi che lo avevano tamponato in West Hollywood, il litigio degenerò in rissa, dovette intervenire la polizia per dividere i litiganti. Hackman raccontò tutta la storia, nei dettagli, al Los Angeles Times: «Un tizio mi è venuto addosso e l’ho steso. Con l’altro siamo finiti a terra, a lottare. Ho assestato un paio di colpi decenti, ma lui mi aveva preso al collo. Brutta storia, ritrovarti atterrato a 72 anni», spiegò, divertitissimo.
Una storia violenta
Sarebbe facile e ingiusto ridurre la vita di Hackman a quella di un uomo con una propensione alla violenza che di questa propensione alla violenza ha capito che farsene. Chi lo ha conosciuto davvero racconta Hackman come una persona estremamente contraddittoria (un esempio: si è sempre definito un liberal ma ha sostenuto due volte il Make America Great Again, prima quello di Reagan e poi quello di Trump). Certo, la violenza l’aveva scoperta assieme alla vita: suo padre riteneva che le punizioni corporali fossero indispensabili per impartire una buona educazione, tant’è che Hackman ha sempre detto che il giorno più felice della sua vita fu quello in cui sua madre decise di divorziare. Nei confronti del padre gli resterà sempre l’odio che si ha nei confronti dei creditori. Ha scoperto quanto potenti siano i gesti, e quindi quanto ammirevole sia il mestiere di attore, grazie a lui. Dopo che il padre se ne era già andato, Hackman lo incontrò per caso durante una passeggiata solitaria: il padre lo vide e l’unica cosa che fece fu fargli un cenno con la mano, prima di proseguire oltre. Quel gesto insignificante fece provare al figlio il dolore più lancinante della sua vita e gli fece decidere che da grande avrebbe fatto l’attore.
Come tutte le vittime di violenza, ne era anche terrorizzato: al ruolo di Jimmy “Popeye” Doyle del Braccio violento della legge, quello che lo ha reso una leggenda hollywoodiana, avrà rinunciato almeno una dozzina di volte. Un giorno, nel mezzo delle riprese, andò dal regista William Friedkin e gli disse che sarebbe stato meglio «cominciare a cercare un rimpiazzo», perché lui stava avendo troppa difficoltà a interpretare un personaggio così violento. Friedkin non gli diede retta non perché non avrebbe voluto – non era un uomo paziente né riconoscente né sentimentale, Friedkin – ma perché non c’era più nessun altro a cui dare quella parte. Lo sapeva pure Hackman, che infatti dopo il successo del film scherzava sempre sul fatto che la sua carriera la doveva tutta a «quei sei che avevano rifiutato la parte prima di me».
La violenza subita sin dall’infanzia aveva reso Hackman tenace e spericolato. Lo stesso spirito che a 16 anni lo aveva convinto ad arruolarsi (con la divisa dei Marines girerà mezzo mondo, andrà in Giappone, Cina, Corea) lo aveva convinto pure a provare prima la carriera da giornalista e poi quella da attore. Al giornalismo rinunciò quasi subito – non era occupazione per uno che durante la giornata sentiva spesso l’impulso di menare le mani – per concentrarsi sul teatro. Gli inizi furono quelli che furono: “The Least Likely To Succeed” della sua classe alla Pasadena Playhouse, appunto, dalla quale fu cacciato dopo un anno soltanto, onorato dal voto più basso mai dato a uno studente del corso. Ma Hackman comunque voleva fare il teatro, pur sapendo che sarebbe dovuto partire dal fondo e che «il fondo del mondo del teatro è veramente un posto di merda».
Dopo la fine prematura della sua carriera di studente, Hackman passò anni a fare quello che capitava (dal commesso al traslocatore a, per lunghi intervalli, il disoccupato), in attesa di farcela. Decise che ce l’avrebbe fatta nel 1955, mentre lavorava come uscire al Times Square Hotel. Un sergente della Marina militare che era stato il suo istruttore, ospite dell’albergo, gli passò accanto, lo riconobbe e «senza mai guardarmi, mi disse che avevo fatto davvero una fine di merda e che lui aveva sempre saputo che nella vita non avrei combinato nulla». Per una volta, Hackman decise che era meglio tenersi i pugni nelle mani e usare quella rabbia a fin di bene. Mollò il lavoro da usciere e fece letteralmente la fame pur di diventare attore.
Dalla disoccupazione al Premio Oscar
E ci riuscì. Prima protagonista di spettacoli Off-Broadway. Poi Broadway. Poi la tv. Nel 1964 conosce Warren Beatty lavorando assieme a lui alla commedia teatrale Any Wednesday. Beatty lo prende in simpatia e lo chiama per girare Lilith. Poi lo chiama di nuovo per interpretare Buck Barrow, il fratello maggiore di Clyde Barrow: grazie a questa parte in Bonnie and Clyde, Hackman è per la prima volta candidato all’Oscar per il Miglior attore non protagonista (che non vince, ma a lui non interessa nulla, gli importa solo che la fame sia finalmente finita). Da questo momento in poi, Hackman diventa uno degli attori più apprezzati e prolifici di Hollywood: fa tre, quattro, cinque film all’anno, quasi ogni anno fino all’autopensionamento del 2004. Lui stesso ammette che la maggior parte dei film che ha fatto «sono delle ciofeche» che ha accettato per togliersi dai guai: ha un lungo e difficile rapporto con il fisco americano, gli piace spendere i soldi che guadagna in jet privati, macchine veloci (era membro dello Sports Car Club of America, partecipò pure a una 24 ore a bordo di una amatissima Toyota da corsa), panfili e investimenti senza senso. Non ha mai avuto paura di tornare povero perché ha sempre pensato che finché il corpo glielo avesse permesso poteva sempre tornare a fare il traslocatore.
Ma anche sui peggiori set del cinema americano Hackman raccoglie ammirazione per quel modo allo stesso tempo istintivo e intellettuale di intendere il mestiere di attore. Alan Parker, regista di Mississippi Burning, lo ha definito «l’attore quintessenziale». Più che minimalista era uno spartano: ogni personaggio lo riduceva a due domande, “in cosa mi somiglia” e “in cosa non mi somiglia”, tanto gli bastava. È stato con questo approccio che Hackman ha trionfato in modi che nessuno avrebbe immaginato per un attore con quel volto e quel corpo e quella voce e quella mimica: poteva essere brutale come nel Braccio violento della legge o patetico come in La conversazione, poteva essere il burbero di Mississippi Burning o lo sperduto dello Spaventapasseri (il suo film preferito tra tutti quelli che ha fatto) o il supercattivo di Superman, il tough guy o lo sfigato. Gli riusciva tutto. Non era solo il brawler o l’every day man, come spesso e ingiustamente è stato descritto. Era un attore capace di mettere tristezza, suscitare pena, far sganasciare dal ridere (mai abbastanza ricordata la sua interpretazione in Frankenstein Jr.). Tutto con quella faccia da minatore, una faccia premiata agli Oscar, a Cannes, nei festival e nelle mostre di cinema di tutto il mondo.
Amare i film, odiare la fama
Certe volte la somiglianza con i personaggi lo mandava in crisi e lo faceva dubitare di sé, perché era uno di quegli attori che prendono il lavoro come una questione privata. In Unforgiven di Clint Eastwood c’è una scena in cui lo sceriffo Daggett, interpretato da Hackman, pesta a sangue English Bob, interpretato da Richard Harris. È una scena violentissima che Hackman, in un’intervista al New York Times, ha raccontato di aver preparato così: «Mi misi a pensare intensamente a quella volta che avevo incontrato Harris e lui non mi aveva riconosciuto ma fece finta di sapere con chi stesse parlando». I due, Hackman e Harris, si erano incontrati una volta sola, quasi trent’anni prima, sul set di Hawaii. Questa maniera di intendere e di svolgere il suo lavoro, questa capacità di «mettere la mano dentro il fuoco», come la definì Arthur Penn, ha fatto di Hackman una leggenda. Era un attore amatissimo dagli attori e temutissimo dai registi (“Vesuvius”, lo chiamavano sul set, ovviamente di nascosto), tutti gli riconoscevano un talento di cui era l’unico detentore. Nessuno è mai stato paragonato a lui, con la sola eccezione di James Gandolfini, un altro uomo enorme, nel corpo e nello spirito, un’altra biografia romanzesca.
Hackman si è ritirato a vita privata quando ha capito che fare film non significava più quello che aveva significato per tutta la sua carriera. Era una cosa che non gli interessava più, preferiva dedicarsi a dipingere i suoi quadri e a scrivere i suoi romanzi storici. La fama lo aveva sempre disgustato, alle feste a Malibu preferiva le nottate al bar: almeno lì, se gli fosse venuta voglia di fare a botte, avrebbe trovato avversari alla sua altezza. La fama lo disgustava a tal punto che, in vecchiaia, l’aneddoto che preferiva raccontare non era uno delle migliaia che avrebbe potuto trarre dai suoi anni di gloria ma uno abbastanza recente, successo dopo che se ne era già andato in pensione. Raccontava sempre di quella volta che una troupe venne a girare una scena di un film proprio vicino alla sua casa di Santa Fe, New Mexico, la casa in cui è morto. Incuriosito, Hackman si avvicinò all’assistente alla regia e chiese se per caso avessero bisogno di comparse. Lei lo guardò e disse «no, signore, mi dispiace». Hackman si fece una grassa risata e se ne andò al bar.

Il libro, uscito 20 anni fa in Francia ma solo adesso in Italia, è il racconto in immagini e parole della breve storia d'amore con il fotografo Marc Marie, attraverso il quale Ernaux tocca tutti i temi che caratterizzano la sua letteratura.

La gioventù e la vecchiaia, la diversità e il conformismo, la Toscana e la metropoli: intervista al frontman del gruppo che ha appena raggiunto un traguardo importante festeggiando con due concerti, a Roma (la scorsa settimana) e Milano (stasera).